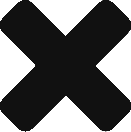Camerun – Dove il tempo sembra essersi fermato
Camerun – Stregato dalla gente e dai colori nel mio primo viaggio in Africa
Camerun Un medico ticinese nel Camerun, il ricordo di Giuseppe Maggi
Dalle foreste alle montagne, dai fiumi ai laghi, dalle dorate spiagge oceaniche ai verdi altopiani, dalla brulla savana al pre-deserto. Perché andare proprio qui? Perché è un continente in miniatura. Salvo le dune di sabbia, propone tutte le caratteristiche tipiche di questa terra
Perché piuttosto che andare in Kenya, Senegal, Etiopia, Tanzania o Mali dovrei recarmi proprio in Camerun? “Perché – risponde Stefano Nori, autore della guida “Polaris” (Firenze 2008) su questo paese – la sua ricchezza e la sua varietà umana e naturalistica sono immense e preziose, uniche e senza uguali in tutto il continente; perché qui un viaggio riserva tante soprese e situazioni inaspettate; perché mille documentari e reportage televisivi non potranno mai rendere giustizia a quanto visto direttamente sul campo. Infine, perché se l’esperienza ha ancora un valore, pur avendo visitato ben 26 stati africani, non mi sono più allontanato da questo bellissimo paese, sin dalla prima volta in cui ci andai, nel novembre 1987”. E anche perché – aggiungiamo noi – in un continente dilaniato da guerre e da pericoli per il viaggiatore, è un’isola di pace e di sicurezza.
Il nostro itinerario, organizzato da Kel 12, prevede una breve tappa a Douala, la capitale economica, per ripartire il mattino seguente verso l’estremo nord, che costituisce un triangolo incuneato tra Nigeria a ovest e Ciad ad est.
Douala, uno dei luoghi con maggiori precipitazioni di tutto il continente, è importante per il suo porto commerciale che serve tutta l’Africa occidentale. È una città particolarmente brutta con i suoi trasandati locali e negozi in stile europeo, che ricordano i tristi periodi dell’epoca coloniale: dall’Occidente sembra infatti aver preso solo il peggio. La sera a cena incontriamo due coppie di italiani che lavorano per aziende europee. Ci raccontano dell’estrema corruzione che regna in Camerun – è considerata la nazione più corrotta al mondo – e di quanto sia sgradevole vivere in questa città, dove gli europei conducono ancora vita separata, come durante il colonialismo. Questa immagine del paese stride profondamente con quella che ci faremo nei giorni successivi, che coincide invece con la descrizione citata sopra di Stefano Nori.
Il nostro volo interno del mattino seguente parte puntuale. Breve sosta tecnica a Yaounde, la capitale, per poi proseguire a nord verso Maroua, che raggiungiamo in un paio d’ore. Maroua, la cittadina più grande del settentrione, si presenta squadrata, con grandi viali urbanisticamente bene ordinati, con basse costruzioni e con un forte carattere di villaggio africano. La sua maggiore attrazione è costituita dal mercato centrale coperto suddiviso in due parti. Una artigianale per turisti, dove si viene aggrediti dai venditori, ed una, per la gente del luogo, suddivisa a seconda delle varie attività, dove spiccano le botteghe dei sarti. In altre zone della cittadina si visitano il quartiere dei fabbri, che producono oggetti riciclando ferro usato, e quello puzzolente delle concerie.
Piccoli regni all’interno dello stato
Una giornata del nostro viaggio è dedicata alla visita della “Chefferie” di Oudjilla, abbarbicata su una collina delle Mandara Mountains. Dista una cinquantina di chilometri da Maroua, ma ci scontriamo subito con uno dei mali del Camerun: le strade. Una gran parte del tragitto odierno si svolge su un’arteria asfaltata, ma cosparsa non di buchi bensì di crateri, tanto da costringere i veicoli quasi a fermarsi per superarli. Abbiamo visto camion fermi ai lati della careggiata in panne a causa delle condizioni stradali, tali da costringerci a tenere una media di 20-25 chilometri orari. Quando poi si giunge alla pista che monta sulla collina, le nostre 4×4 stentano a salire, tanto è cosparsa di sassi. Forse a piedi saremmo stati più veloci, ma i raggi del sole sono troppo cocenti. Sulla strada incontriamo diversi villaggi costituiti da assembramenti di “saré”, cioè di capanne rotonde collegate tra loro per ospitare un nucleo familiare. Con i loro tetti in paglia ed i muri in mattoni di banco (costituiti di terra, paglia e sterco di animale) sembrano appartenere al paesaggio. La “Chefferie” conta 25 villaggi e circa 30 mila abitanti. Ma prima di continuare la mia descrizione è necessario spiegare che cosa è una “chefferie”. È una sorta di regno all’interno dello stato e riconosciuto dal governo centrale. Questi regni, con compiti simili a quelli dei nostri comuni, giocano un ruolo fondamentale nella vita culturale e politica del Camerun. Lo stato, oltre a riconoscerli, basa gran parte della sua struttura sociale sull’autorità morale degli “Chef”, che sono accettati dai cittadini e che tramandano il loro potere ai discendenti di sangue. Esercitano funzioni giuridiche, politiche e spirituali, come vedremo nella Chefferie di Oudjilla, con un’autorità che si estende su tutti i campi della vita quotidiana. Il centro simbolico di questo potere è il palazzo. Ed allora entriamo nel “palazzo” di Oudjilla.
Visita al palazzo reale di Oudjilla
Ad accoglierci c’è il vecchio regnante, stravaccato su un lettino in legno con uno scopino in mano per difendersi dalle mosche, davanti a un vecchio televisore spento. Sostiene di avere già compiuto i cento anni, ma francamente sembra più giovane. Fa fatica ad alzarsi e ci saluta sdraiato. Ha 50 mogli e 113 figli. Parla a stento il francese, ma uno dei figli funge da traduttore. Alle nostre domande risponde evasivamente. Non così il principe ereditario – il secondo genito, poiché secondo la tradizione il primogenito è considerato meno intelligente – che nel frattempo ci ha raggiunti. Veste una tuta blu da meccanico, nonostante stesse lavorando nei campi, e parla perfettamente il francese. Ci accoglie con calore, anche perché da oltre un mese non riceve visite da turisti, e ci introduce nel palazzo. È costituito da un enorme assembramento di capanne simili a quelle prima descritte. Basti pensare che ognuna delle 50 mogli ha diritto a quattro unità, ma molto anguste: una per dormire, una per cucinare e due come deposito per il miglio.
La prima sala del palazzo è dedicata alle udienze. Lo chef svolge infatti un ruolo simile al nostro giudice di pace. Dirime dissidi legati soprattutto a divorzi e a questioni ereditarie, mentre i reati più gravi vengono demandati ai tribunali dello stato. Proseguiamo la nostra visita ed entriamo in una stalla molto buia, dove viene custodito il bue sacro. Per tre anni vive lontano dalla luce in uno spazio angusto affinché ingrassi, sino al sacrificio rituale che avviene nel periodo della raccolta del miglio tra novembre e dicembre. Nella capanna successiva sono conservate le urne funerarie degli antenati. Si accede quindi al quartiere delle mogli, che sono governate dalla prima consorte. Lo “chef” non dorme mai nelle loro stanze, ma sono le donne che a turno si recano nella sua abitazione posta all’esterno del “saré”, così come quelle dei figli adulti. Il “palazzo” è provvisto di corrente elettrica, ma non di acqua. Ed i pozzi sono lontani.
Ci incamminiamo con il principe ereditario verso una collina da cui si gode una splendida vista sulla campagna e sulle montagne circostanti. Tra i tanti tetti in paglia ne spiccano alcuni in lamiera. Gli chiediamo come vede il futuro della sua comunità. Non sarà infatti facile conciliare la conservazione di quel patrimonio etnico-culturale con i veloci e continui mutamenti della società, che stanno cominciando a giungere anche lassù. Con espressione preoccupata risponde di voler rimanere fedele alle tradizioni, ma di rendersi conto che dovrà fare i conti con il modernismo. Sarà quindi necessario, aggiunge, accettare molti compromessi. Ma la sua speranza è che Oudjilla venga in futuro considerata patrimonio mondiale dell’Unesco, perché è convinto che questo riconoscimento gli procurerebbe i mezzi necessari per conservare le tradizioni, con il rischio però, aggiungiamo noi, di diventare una sorta di riserva o di museo all’aperto.
Le attività ai bordi della strada
Se le strade sono sconnesse, i panorami che presentano valgono bene la scomodità del tragitto. E, soprattutto, sono luogo di vita. Così attraversando un ponte ci imbattiamo in un gruppetto di ragazzini che fanno il bagno nudi in un pozzo d’acqua e si divertono quando mostriamo le foto dei loro tuffi. Poco più avanti ci fermiamo per osservare un gruppetto di giovani donne che travasano da un recipiente all’altro i grani di miglio facendoli cadere dall’alto per ripulirli. Ripetono quel movimento più volte facendo sembianza di non vederci, ma quando ci avviciniamo ci sorridono e accennano qualche parola in francese. La gente in questo paese è molto dolce e disponibile: credo siano questi incontri l’esperienza più ricca del nostro viaggio. Attraversando i villaggi si notano bancarelle in cui si vende di tutto, anche se solitamente il mercato si svolge in un giorno ben preciso della settimana. Si commercia anche carne appena macellata. Sui bordi della strada assistiamo alla cruenta macellazione di uno zebù, una sorta di bue africano. Vediamo le interiora dell’animale sgozzato giacere sulla pelle distesa per terra come una tovaglia. Due giovani si accaniscono con una mazza sulla povera bestia, che viene ridotta in pezzi da vendere al vicino mercato.
Itinerario
1° giorno
Italia-Douala
2° giorno
Douala-Maroua
3° giorno
Maroua (il mercato settimanale) – Maga
4° giorno
Maga-Pouss (il mercato settimanale) – Waza
5° giorno
Waza-Oujilla-Col di Koza-Mokolo
6° e 7° giorno
Mokolo-Tourou (il mercato settimanale) – Roumsiki
8° giorno
Roumsiki-Mayo Plata (il mercato settimanale) – Maroua
9° giorno
Maroua-Douala-Parigi
Bibliografia
Camerun, il paese dei mille villaggi Polaris, Firenze 2008
Costa d’Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Cameroun Lonely Planet, Torino 2010