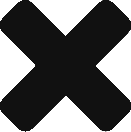Tibet – Il Tibet è un Paese occupato dai cinesi
Cina – Un mondo svelato dalla Via della Seta
Cina – La Cina immaginata e quella della realtà
Con la Transtibetana, chiamato il “treno dei cieli”, alla scoperta di una cultura portata storicamente a prediligere l’essere all’avere. Nonostante si tratti di un Paese militarmente occupato dai cinesi, l’animo mistico di questo popolo lo si respira visitando gli affascinanti monasteri.
A Lahsa con la ferrovia più alta del mondo
Proseguo con la parentesi Tibetana il mio diario di un viaggio di approccio alla Cina e al Tibet. Un viaggio a volte faticoso a causa dell’altezza elevata: Lahsa è situata a 3600 metri e durante gli spostamenti si toccano i 5 mila. Dopo un periodo di acclimatazione di un paio di giorni ci si muove comunque di nuovo senza fatica.
Il treno che ci porterà nella capitale lo prendiamo a Xining, a 90 minuti di volo da Pechino. A 37 chilometri da Xining sorge Ta Er Si, Kumbum nella lingua del Paese delle Nevi, città natale di Tsong Kha pa (1357-1419) il fondatore del buddismo tibetano, a cui è dedicato un vasto monastero fondato nel 1560. Non lontano da quel luogo il 6 luglio 1935 è nato anche l’attuale capo religioso del Tibet, il XV Dalai Lama, in esilio in India e molto noto in occidente per aver vinto il premio Nobel per la pace.
Il treno dei cieli
Inizia con la visita di questo luogo sacro, con pellegrini che giungono da tutto il paese, il nostro itinerario tibetano, che ci porterà a Lahsa con la Transtibetana, la linea ferroviaria che collega Pechino alla capitale del Tibet. Soprannominato il “Treno dei cieli” questo capolavoro ingegneristico è frutto di un’idea del presidente Mao, ma è stato costruito recentemente ed inaugurato nel 2006, dopo cinque anni di lavori. È una ferrovia sul tetto del mondo: il suo percorso si snoda sempre sopra i 4 mila metri e a tratti supera i 5 mila. Una buona metà del tracciato poggia sul ghiaccio. Per evitare la deformazione dei binari, a causa del disgelo estivo, è stato necessario realizzare in molte tratte un sistema di raffreddamento con tubature sotterranee che mantengono il terreno ghiacciato durante tutto l’anno. Secondo il presidente cinese Hu Jintao quest’opera serve a “consolidare l’unità nazionale”, mentre a parere del Dalai Lama è solo un tassello della politica di cinesizzazione del Tibet. Al di là di queste tristi considerazioni politiche il viaggio sulle carrozze pressurizzate della Transtibetana è estremamente suggestivo. Soprattutto quando per una decina di ore si attraversa un vastissimo altipiano ricco di piccoli villaggi rurali, dove l’attività principale è costituita della pastorizia. Dai finestrini si vedono migliaia di yak, una mucca locale, pascolare in paesaggi mai monotoni ed in continuo divenire. Ai confini della smisurata pianura, attraversata da fiumi e laghi d’inverno gelati, si intravedono le cime innevate delle montagne, che toccano i 7 mila metri. Durante il percorso in treno sono rimasto come un bimbo per ore e ore con il naso incollato al finestrino, incantato da quel paesaggio tanto differente dal nostro, anche se di alta montagna. Prima di giungere in Tibet si passa un territorio desertico, non abitato, e quindi meno interessante, anche se ci ha permesso di osservare alcuni animali selvatici. Dopo 24 ore di treno da Xining e una notte trascorsa nelle cuccette si arriva a Lahsa.
La mistica Lahsa
Tra anonimi viali a più corsie e squallidi quartieri dormitorio sopravvivono interessanti monumenti del passato. Il luogo più piacevole della città è senza dubbio il cosiddetto Barkhor, il quadrilatero di animatissime stradine su cui si affaccia un coloratissimo mercato che circonda il Jokhang, l’edificio sacro più venerato del paese. Come fa giustamente notare l’autore della guida Lonely Planet, “si tratta di una zona che non ha eguali in tutto il Tibet per il modo straordinario in cui le più sincere espressioni di fede si armonizzano con le manifestazioni di un’improvvisata economia di mercato”, simpaticamente espressa da bancarelle e negozietti che hanno resistito a qualsiasi infiltrazione del mondo moderno. Così come sembra appartenere ad altre epoche la religiosità dei numerosi pellegrini che pregano con tutto il corpo e si prostrano gettandosi a terra davanti al tempio, tanto da aver lucidato nel corso dei secoli le grosse pietre del selciato. In questo quartiere si respira ancora la magica atmosfera di un tempo, malgrado la minacciosa presenza di giovani militari cinesi catapultati dal potere politico in un mondo a loro estraneo. La sera, di ritorno dalle gite fuori città, si torna sempre volentieri in questo centro storico, dove è bello lasciarsi trascinare lungo il cammino percorso in senso orario dalla massa di pellegrini che si recano al Jokhang, il tempio che ospita la statua del Buddha più venerata del Tibet. La visita di questo luogo sacro è una delle esperienze più autentiche che si possono vivere in questo paese.
Potala tesoro tibetano
Ma il simbolo del “Tetto del Mondo” è il Potala, considerato uno dei tesori più preziosi dell’intera architettura asiatica. Era il cuore pulsante e il punto di riferimento religioso, sociale e culturale di tutto lo sterminato “Paese delle Nevi”. Prima di entrarvi i pellegrini lo circoambulano con deferenza. Si tratta di un’imponente struttura seicentesca, simile per molti aspetti a un’inviolabile fortezza, che non mancherà di stregarvi. È stata per molti secoli sede del governo tibetano e dimora di tutti i Dalai Lama che si sono susseguiti. Dopo aver salito a fatica gli scalini che vi portano ai tredici piani di questo monumento è deludente notare come sia ormai privo di pathos: è infatti stato trasformato in museo dai cinesi, persino nella sua parte religiosa (Il Palazzo Rosso), dove al posto dei monaci vi accolgono guardie armate.
Decisamente più vissuto è invece il Drepung, situato a 8 chilometri dalla capitale. Un tempo, con i suoi 8 mila monaci, era considerato il più grande monastero al mondo. Fu costruito nel XV secolo ed i Dalai Lama esercitarono da queste mura il loro potere religioso prima di trasferirsi nel Potala. Visto da lontano assomiglia a un piccolo villaggio con i suoi edifici bianchi ammassati sul fianco della collina. Quando lo abbiamo visitato, la settimana precedente il capodanno tibetano, era frequentatissimo da pellegrini, che giungevano dalla campagna. Questo monastero, come quello di “Sera”, che dista pochi chilometri, era famoso per i suoi colleghi dove si insegnava il buddismo.
Verso il Nepal
Lasciamo Lahsa il mattino di buonora per una gita di due giorni in torpedone lungo l’antica strada che porta verso Kathmandu nel Nepal. Attraversiamo paesaggi lunari, brulli, color della pietra, dove tutto ad un tratto sbuca un ghiacciaio. Le case dei contadini sono in sasso. Il piano terreno è solitamente adibito a stalla, sopra abita la famiglia. Data l’assenza assoluta di legna, per riscaldare gli ambienti durante l’inverno, si utilizza lo sterco d’animale seccato a forma di mattonelle durante la bella stagione e ordinatamente sistemato in bella vista davanti alle abitazioni. Dopo alcune ore di viaggio raggiungiamo un piccolo pianoro a quota 4794 metri da cui si gode una splendida vista sul lago Yamdrock dall’insolita forma tortuosa e con la superficie ghiacciata. A sud svettano le alte montagne innevate dell’Himalaya. Si notano piccoli terrazzamenti che nella bella stagione sono coltivati ad orzo, cereale che cresce anche sopra i 4000. Il lago è considerato sacro dai tibetani. Credono sia la dimora delle divinità irate, ma ospita anche la maggiore centrale idroelettrica del paese. Proseguiamo e di tanto in tanto sulle vette scorgiamo i cosiddetti cavalli del vento, corde a cui sono appese bandierine colorate che recano preghiere stampate, trasportate simbolicamente di montagna in montagna e di valle in valle dal vento che qui non manca mai. Dopo aver superato il passo più alto del viaggio a quota 5200 metri raggiungiamo Gyantse, un’affascinante cittadina cinta dalle mura e dominata da un imponente castello, considerata anticamente la porta del Nepal. Circondato da un uno splendido anfiteatro di monti aridi che lo proteggono naturalmente, sorge il grande complesso architettonico del monastero del Pelkor Chode, che accoglieva quindici monasteri in cui coesistevano tre diversi ordini del buddismo tibetano. È certamente uno dei siti più suggestivi visitati durante il soggiorno in Tibet, per la sua autenticità e l’elevato numero di pellegrini che si recano in quel luogo per pregare. Il sito ospita un tempio quattrocentesco, unico al mondo, costruito con la forma di un mandala a 108 facce e composto da 112 cappelle riccamente affrescate, che i fedeli percorrono in senso orario pregando.
In serata raggiungiamo Xigatse, dove trascorriamo la notte e il mattino seguente visitiamo un altro suggestivo monastero, Tashilhunpo, molto frequentato dai credenti. È la discussa sede ufficiale dei Panchen Lama: l’undicesimo scelto dai cinesi risiede qui a Pechino. È considerato oggi la più grande sede monastica del Tibet. Fondato alla metà del Quattrocento è perfettamente conservato e appare ai visitatori come un’imponente città fortificata. Custodisce, oltre alle tombe dei Panchen Lama, la più grande statua dorata al mondo. Raffigura il Buddha del futuro e per realizzarla sono stati impiegati 300 chilogrammi d’oro.
La nostra parentesi tibetana è terminata. Rientriamo a Lahsa per una strada in gran parte non asfaltata, che percorre due valli disabitate e offre paesaggi lunari. Giungiamo nella capitale troppo tardi per visitare la residenza estiva del Dalai Lama – Norbulingka – da cui nel 1959 fuggì travestito da soldato tibetano l’attuale leader religioso in esilio.
Itinerario
1° giorno
Milano-Pechino
2° giorno
Pechino e Tempio del cielo, che per cinque secoli ha rappresentato il cuore dei cerimoniali e del simbolismo imperiale
3° giorno
Tomba dei Ming – Grande Muraglia, un’impresa ingegneristica sbalorditiva, lunga 6.350 chilometri
4° giorno
La città proibita, una vera e propria città nella città con oltre 800 edifici – Crociera sul lago Kumming
5° giorno
Xining – Monastero di Kumbum – Lhasa
6°giorno
Ferrovia tibetana – Lhasa, nota anche come “Tibet Express”, oltre 1.100 km per collegare Cina e Tibet
7° giorno
Lhasa – Palazzo Potala – Tempio Jokhang
8° giorno
Monastero di Drepung
9° giorno
Lago Yamdrok – Gyantse
10° giorno
Xigatse, sorge alla confluenza del Yarlung e del Nyangchu
11° giorno
Lhasa, capitale della Regione Autonoma del Tibet. In passato anche residenza tradizionale del Dalai Lama
12° giorno
Da Chengdu, punto di snodo per i trasporti e le comunicazioni della Repubblica popolare cinese, a Shanghai, una delle città più popolose al mondo
13° giorno
Shanghai, con oltre 18.5 milioni di abitanti
14° giorno
Shanghai-Milano